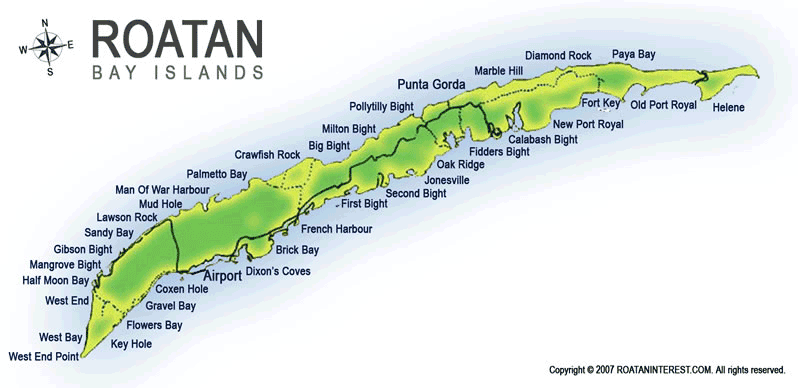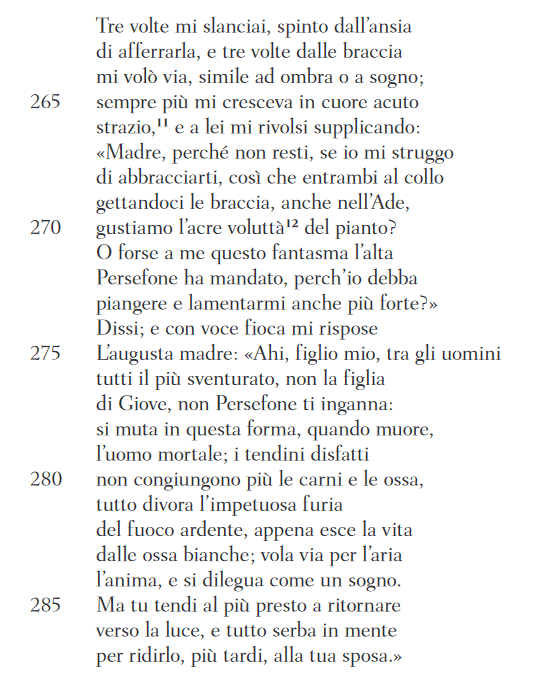Sono sempre stato affascinato dagli Eroi. Gli eroi dal cuore umano, dall’animo sensibile. Non parlo di quelli che finiscono sul giornale. Intendo quelli che con un gesto riescono a girare la ruota del destino. Tipo Merzario quando si lanciò tra le fiamme per tirare fuori Lauda dal rogo del Nurburgring nel ’76.
Era chiaro che il Destino aveva deciso, doveva andare in quel modo. Tutto stabilito, tutto scritto. E invece no, dal fumo rovente salta fuori questo omino che ti cambia il finale.
Allo stesso modo mi incanta parlare di storie eroiche, talmente piene di fascino che l’aria sembra immobile. Impalpabile, sospesa, magica, eterna.
Oggi voglio scrivere di una delle storie che mi raccontava mio padre, che a sua volta l’aveva sentita di chissà chi. La raccontava, però, con una intensità che sembrava davvero l’avesse vissuta e ogni volta si appassionava come se la stesse rivivendo. Il suo coinvolgimento nel racconto, questo flusso che gli usciva esondando dall’emozione, non voleva solo dire “senti questa storia”. Lui voleva dirmi “ascolta bene, e lasciati sempre guidare dal cuore”.
L’ho raccontata qualche giorno fa ad Albi, ancora l’ho fresca in mente, anche se naturalmente a lui ho proposto una versione meno dettagliata di questa, arricchita da riferimenti bibliografici. Eccola qui.
Olimpiadi di Berlino, 1936. La grandiosità colossale delle strutture sportive, pianificate fin nei minimi dettagli dall’architetto del regime Albert Speer, mirava ad infondere negli spettatori una forma di temibile rispetto per il potere nazista. Con chiari richiami ai modelli architettonici dell’Antica Grecia, l’Olympiastadion, di recente costruzione dopo l’incendio del Reichstag, poteva contenere oltre centodiecimila spettatori. Maestoso ed immenso, costituiva un’autentica macchina di propaganda messa in azione dal regime per ottenere consensi. All’insaputa del resto del mondo, una manifestazione sportiva stava per essere trasformata in uno strumento di battaglia ideologica.
Hitler intendeva servirsi delle Olimpiadi per dimostrare la supremazia della razza ariana, di conseguenza l’atleta tedesco doveva corrispondere all’immagine stereotipata: alto, biondo, prestante, carnagione chiara e occhi azzurri. In questa categoria rientrava perfettamente Carl Ludwig Long, detto Luz, un ventitreenne studente di legge di Lipsia, nonché atleta della Leipziger SC. Long aveva già dimostrato in precedenza le sue doti, superando per due volte consecutive nel salto in lungo il record olimpico di 7,73 m stabilito nel 1928 ad Amsterdam dallo statunitense Edward Hamm. Era diventato il beniamino della nazione dopo essersi classificato terzo ai campionati europei di atletica leggera, nel 1934. Una pedina d’oro, quindi, che non poteva mancare nella scacchiera schierata da Hitler per affermare il dominio sportivo germanico.
Agli occhi del Führer il trionfo di Long appariva quasi scontato e il dittatore si preparava a pregustarlo.
Alle Olimpiadi avrebbero partecipato ben quarantanove Paesi, un numero record rispetto alle edizioni precedenti, che tuttavia non teneva conto della forte discriminazione insita nell’evento berlinese. Gli atleti ebrei-tedeschi furono espulsi da tutte le discipline sportive, mentre un destino già più felice toccò agli afroamericani, ai quali fu concesso gareggiare, anche se in numero minore. Una squadra olimpica americana presentava una media di diciotto atleti di colore su 312 partecipanti, una percentuale bassissima. Ancor più bassa tenendo conto che quei diciotto subivano una pesante discriminazione perfino in patria. Erano pochi, ma abituati alle privazioni, forse per questo motivo ancor più desiderosi di riscattarsi. Uno di loro si chiamava James Cleveland Owens, ma tutti lo conoscevano come Jesse.
La presenza degli afroamericani venne giustificata da Hitler con sordido disprezzo: essendo un popolo primitivo potevano vantare una costituzione robusta, perciò più adatta alla corsa. A rincarare l’acredine fu il quotidiano della propaganda nazionalsocialista, diretto da Joseph Goebbels, che definiva i neri come ausiliari degli Stati Uniti. La realtà si mostrava sotto una luce del tutto diversa: gli afroamericani, nel loro Paese, erano costretti a sedere nella parte posteriore dell’autobus, dovevano utilizzare gli ascensori di servizio negli alberghi: essere confinati ai margini era la loro condanna. Al contrario degli ebrei tedeschi, certo, il diritto di vivere non era loro precluso, eppure, sottilmente, silenziosamente, veniva negata loro quella possibilità che si trova alla base della libertà stessa: vivere come volevano.
Lo sapeva bene Jesse, figlio di Henry Cleveland Owens, un povero agricoltore dell’Alabama, che a otto anni lavorava già come inserviente per meritarsi un posto un po’ più accettabile in quel mondo deciso ad escluderlo. A scuola l’insegnante non riusciva a comprendere il suo slang, così, quando lui disse: «Mi chiamo J.C.», comprese Jesse. Quel nome, nato da un’incomprensione, divenne la sua nuova identità, simboleggiava meglio di ogni metafora l’adattamento forzato a cui era stato costretto per sopravvivere fin dalla più tenera età. Furono le sue capacità atletiche a consentirgli una borsa di studio per la Ohio State University, dove incontrò Lawrence Snyder, detto Larry, uno dei migliori coach in circolazione.
Jesse cominciò a segnare i suoi record. Nel 1935 al Big Teen Meet ad Ann Arbor, in Michingan, stabilì 4 record del mondo in 45 minuti: lungo (8,13 m.), 100, 200 e 200 ostacoli. L’eccezionalità delle sue imprese lo condusse a Berlino.
Owens correva stretto nel pugno chiuso del Führer, accanto ad atleti che con la sua storia non avevano nulla da spartire. Luz Long aveva le mani delicate di chi nella vita non ha sfogliato altro che libri, eppure lesse nei suoi occhi scuri ciò che non avrebbe intravisto nessun altro.
Il sole appena sorto quel 4 agosto vedeva Jesse Owens già vittorioso: il giorno prima la medaglia d’oro dei cento metri splendeva con lui sul gradino più alto del podio.
I suoi successi lo precedevano, tuttavia i giudici tedeschi non esitarono a sollevare per ben due volte la bandierina rossa durante le qualificazioni per il salto in lungo.
Fece il primo salto per saggiare il terreno, indossando addirittura i pantaloni delle tuta, perchè negli States il primo salto è sempre di prova. Alle Olimpiadi, no: nullo. Nel frattempo, nemmeno il tempo di pensare come mai nessuno lo avesse informato, in pista c’erano le batterie dei 200 metri e lo chiamarono alla partenza. Vinta la sua batteria, arrivò al secondo salto imballato, con le gambe dure e poco concentrato. Nullo, anche questo.
Dopo due salti nulli incombeva su di lui lo spettro dell’eliminazione. Jesse era dotato di grande velocità, ma il suo stile rivelava imperfezioni, soprattutto se confrontato con l’impeccabile sospensione hang style dell’idolo di casa Luz Long, quell’angelo biondo che volava da un lato all’altro della vasca. Per Owens sembrava ormai preannunciarsi l’inevitabile sconfitta, senza contare che ormai su di lui pesava duramente la fatica degli sforzi precedenti. Anche la giuria percepiva questa sua difficoltà e già si apprestava a dichiararlo fuori gioco senza troppi ripensamenti. Anzi, in realtà non vedevano l’ora. Rimaneva l’ultimo salto, un’unica possibilità.
Jesse si trovava di fronte all’ultimo salto valido per accedere alla finale, quando qualcuno si avvicinò alle sue spalle. Era Luz, l’atleta tedesco di cui tutti attendevano la vittoria, che cercava di esprimersi con quel poco di inglese imparato a scuola.

“Uno come te dovrebbe essere in grado di qualificarsi ad occhi chiusi” disse, “no, non sono tranquillo, oggi non trovo il punto di stacco” rispose Owens scuotendo la testa, mille pensieri a corrersi dietro.
Allora Luz Long, l’angelo biondo, senza dare troppo nell’occhio si mise a cercare sulla pista le impronte già lasciate da Jesse ed iniziò poi a misurare la pedana con alcuni passi. Ad un certo punto si fermò e fece cadere un fazzoletto bianco accanto alla pedana, ponendolo 30 centimentri più indietro dell’impronta dell’ultimo salto di Owens.
Eccolo, era quello il punto di stacco migliore che Owens non riusciva a trovare per fare il suo salto valido. Long accompagnò il gesto con un’occhiata di intesa che non si aspettava di essere delusa, e la conferma non tardò.
Perché Luz, ariano fra gli ariani, probabile Dio in terra in caso di vittoria, avrebbe dovuto aiutare Jesse Owens? Perché compromettere una vittoria in quel modo, davanti agli occhi di tutti gli alti gerarchi nazisti, davanti ad Adolf Hitler?
Perchè se avesse dovuto vincere, Luz Long avrebbe voluto farlo battendo il più forte di tutti; perché ne era in grado, perché vincere senza il rivale, quello vero, non equivale a vincere per davvero. E perché Luz era un uomo di classe, uno sportivo, sapeva bene cosa significasse la parola sacrificio. E infine perché Luz, lui no, nazista non lo era.
In semifinale – e poi in seguito in finale – i due si misurarono su distanze proibitive per gli altri avversari; una rincorsa alla medaglia che spostò, di salto in salto, sempre un po’ più in là l’asticella e lo stupore, l’attesa e l’adrenalina, fino a quando l’ultimo nullo di Long decretò la vittoria di Jesse.
Luz, già eliminato, alzò il braccio di Jesse, incoronandolo prima ancora che la cerimonia ufficiale se ne prendesse carico; il tedesco ariano che secondo l’ideologia di casa sua avrebbe dovuto odiare il nero americano era lì, ad aspettarlo.
Owens vinse l’oro saltando ben 8.06 m contro i 7.87 del tedesco, e volle festeggiare a modo suo, con un ultimo salto in piena armonia e serenità, su pista bagnata, oltre gli otto metri. A pochi centimetri dal suo record del mondo.

All’ultimo salto per Jesse, di fronte alla vasca di sabbia del salto in lungo c’era Luz, solo lui.
Jesse camminò in aria, giungendo in quella vasca dopo un’esplosione di potenza ed eleganza sconosciute; atterrò più lontano di tutti, anche di Luz.
Luz lo attendeva laggiù, in fondo a quella vasca che per loro era stata campo di battaglia, metro di paragone, dimensione in cui sentirsi perfettamente ed assolutamente uguali.
Long andò incontro a Owens, lo abbracciò e i due, insieme, si incamminarono verso il tunnel degli spogliatoi.
Luz, fisico imponente e figlio di quella borghesia lipsiana i cui libri andarono al rogo per volere di una ideologia folle, aveva perso. Ma era felice.
I due migliori saltatori in lungo al mondo avevano misurato le loro immense capacità di fronte a centomila spettatori, nello stadio più imponente dell’epoca, durante le Olimpiadi più colossali fin lì realizzate
Alla premiazione Jesse, frastornato e forse anche un po’ imbarazzato, investito da un turbinio di emozioni difficili da controllare, si tenne saldo al braccio di Long che, con la sua fiera impostazione teutonica lo accompagnò nella pancia dell’Olympiastadion.
Lo stadio più bello, più grande, lo stadio del Führer.

Vinse così il suo secondo titolo. Fu uno scacco per Hitler che riponeva ogni speranza in Long per un trionfo nell’atletica leggera, disciplina nella quale la sua fucina di atleti aveva dimostrato una certa carenza. Di certo, il Führer non poteva sapere che era stata proprio la sua “scommessa vincente” a tradirlo fraternizzando con il rivale.
Si vociferò a lungo sulla reazione di Hitler al fallimento, gli attribuirono i comportamenti più disparati come l’essersi rifiutato di stringere la mano all’afroamericano, ma Jesse smentì le malelingue affermando di essere stato salutato, sebbene a distanza, dal Führer. Owens nella sua biografia afferma: “Quel giorno, dopo essere salito sul podio del vincitore, passai davanti alla tribuna d’onore per rientrare negli spogliatoi. Il cancelliere tedesco mi guardò, si alzò in piedi e mi salutò con un cenno della mano. E io feci altrettanto. Penso che giornalisti e scrittori mostrarono cattivo gusto inventando poi un’ostilità che non ci fu affatto” (da The Jesse Owens Story, 1970).
Secondo la testimonianza diretta del grande Arturo Maffei, quarto classificato con lo storico primato italiano di 7,73 metri che avrebbe resistito fino al 1968: “Nel tunnel Hitler andò davanti a Owens e gli fece il saluto a braccio teso, proprio nel momento in cui Jesse gli tendeva la mano per stringerla. Allora fu Hitler a tendere la mano, ma intanto Owens, correggendo il primo atteggiamento, aveva portato la sua alla fronte per eseguire il saluto militare. Questione di secondi, poi Hitler passò oltre. Decidete voi chi fu a rifiutare la stretta di mano. Ma andò proprio così: alla Ridolini.” (da Arturo Maffei: un salto…lungo una vita, Gustavo Pallica, 1999)

Ben diverso si dimostrò invece il comportamento del presidente americano Franklin Delano Roosvelt che, troppo occupato a raccogliere i voti degli stati del sud in previsione delle elezioni imminenti, non si degnò neppure di accogliere il vincitore olimpico alla Casa Bianca come prevedeva la tradizione. Jesse aveva battuto ogni record vincendo il maggior numero di gare in un’Olimpiade; oltre ai successi nei 100 metri e nel salto in lungo aveva infatti conquistato il primo posto nei 200 metri e, il 9 agosto, nella staffetta 4×100, eppure il presidente Roosvelt cancellò l’appuntamento. “I wasn’t invited to shake hands with Hitler, but I wasn’t invited to the White House to shake hands with the President, either.” (Owens pierced a myth, Larry Schwartz, ESPN, 1999)
L’amicizia fra Jesse e Luz continuò ad esprimersi attraverso le lettere, l’unico mezzo con cui potevano sfidare i venti di guerra che infuriavano separandoli.
L’eco di quel consiglio in gara continuò a perpetuarsi attraverso le parole, facendosi beffe dei piani di morte. Non sarebbe dovuta seguire una guerra per dimostrare l’insensatezza della follia nazista. L’errore era già chiaro, come scrisse Luz in una delle sue lettere: “Tutte le nazioni del mondo hanno i propri eroi, i semiti così come gli ariani. E ognuna di loro dovrebbe abbandonare l’arroganza di sentirsi una razza superiore“.
Jesse, l’eroe di quell’Olimpiade, non diede mai molta importanza a quelle sue 4 medaglie che neppure in patria gli vennero riconosciute con il rispetto che meritavano.
Quando, rientrati negli Stati Uniti, lui e Larry Snyder si fermarono a festeggiare in un ristorante, Owens venne obbligato ad entrare dal retro, nonostante le proteste del suo allenatore. E una volta a casa, poi, ritornato alla normalità, dovette adattarsi a quel mondo ostile facendo i lavori più disparati, fra cui anche l’inserviente in una pompa di benzina. Per guadagnarsi da vivere gareggiava in eventi a pagamento contro cavalli, cani e motociclette.
Dovette attendere anni prima che venissero riconosciuti i suoi successi sportivi e, anche quando venne acclamato all’unanimità, gli rimase un’unica certezza: “Si potrebbero fondere tutte le medaglie che ho vinto, ma non si potrebbe mai riprodurre l’ amicizia a 24 carati che nacque sulla pedana di Berlino“.
Quel che accadde il pomeriggio del 4 agosto 1936 nello stadio olimpico di Berlino apparve agli occhi del mondo come uno schiaffo al regime nazista nel fulcro del suo potere: una medaglia d’oro vinta da un uomo di colore nel salotto buono della Germania ariana.

Tuttavia non fu quella medaglia, per quanto splendente, a suggellare la vittoria più importante della giornata.
Fu invece ben più considerevole la vittoria umana: un’amicizia nata sul campo di gara, a dimostrare che la rivalità non si traduce sempre in antagonismo. E che il valore di un’amicizia non si misura nel momento in cui nasce, ma dalla sua capacità di sopravvivere al tempo.
Il legame fra l’atleta tedesco Luz Long e l’avversario afroamericano Jesse Owens trova la sua più valida conferma in quella lettera, ultima di una fitta corrispondenza, spedita dal fronte di guerra:
“Dopo la guerra, va in Germania, ritrova mio figlio e parlagli di suo padre. Parlagli dell’epoca in cui la guerra non ci separava e digli che le cose possono essere diverse fra gli uomini su questa terra. Tuo fratello, Luz”.
Così scriveva Long, divenuto ufficiale della Luftwaffe tedesca, a Owens, appresa da poco la notizia della nascita del suo primogenito.
Era accaduto, infatti, che nel 1941 per Long era arrivato il giuramento alla Wehrmacht, l’esercito tedesco, già in guerra da due anni. Dopo un rapido addestramento fu prima mandato il Polonia con la contraerea e quindi a combattere nel Sud Italia. Si preannunciava un luglio afoso, in Sicilia erano sbarcati gli americani contro i quali era tenuto a combattere in nome della patria. Il suo status di atleta internazionale gli aveva risparmiato di prendere parte al conflitto iniziato nel 1939, ma il capovolgimento delle sorti della guerra richiamava al servizio del Reich perfino gli esponenti più illustri della nazione. Le circostanze avevano condotto Long a gestire la spedizione contro gli americani, azione che, in cuor suo, doveva sentire come profondamente ingiusta. Proprio ad un americano, infatti, scriveva nei momenti più bui intessendo pensieri di pace, in ricordo di un momento perduto in cui entrambi sorridevano con un medaglia appuntata sul petto.
Luz sapeva che istanti simili non sarebbero più tornati, per questo ne affidava ad Owens la memoria e il compito di tramandarli. Avrebbe trovato la morte in quella Sicilia arsa dal sole estivo, ferito gravemente a Gela il 10 luglio 1943: morirà dopo quattro giorni di agonia in un ospedale da campo nei pressi di San Pietro.
Fu così che Long trovò la morte a trent’anni durante la seconda guerra mondiale nel corso dell’operazione Husky, che vide gli Alleati sbarcare in Sicilia. Di stanza a Niscemi con la divisione corazzata “Hermann Goring”, fu coinvolto nei feroci combattimenti per la difesa dell’Aeroporto di Biscari-Santo Pietro nell’attuale territorio di Acate.
Le cause della morte non sono certe, la più plausibile è quella dell’aggravamento dovuto alle ferite, una in particolare, per un proiettile alla coscia che gli impedì la ritirata insieme al resto dell’esercito tedesco. Trovato da un suo commilitone sul ciglio della strada, fu portato nel vicino ospedale da campo dove morì il 14 luglio 1943. Fu sepolto in un cimitero provvisorio e poi la sua salma fu trasferita dagli americani nel 1961 al cimitero militare germanico di Motta Sant’Anastasia mentre era in costruzione. I luoghi dello sbarco nella Piana di Gela risultano ancora oggi visitabili, grazie alla conservazione dei bunker e camminamenti dell’epoca che formavano la prima linea di difesa costiera.

Owens, da parte sua, mantenne la promessa: incontrò Kai-Heinrich, il figlio di Luz. Qualche anno dopo partecipò anche alle sue nozze, gli raccontò ciò che era stato quell’uomo svanito anni prima in un Paese lontano.
A proposito dei trionfi di suo padre, Kai-Heinrich Long dirà che non valevano un quarto di quella medaglia d’oro mancata per un soffio o, piuttosto, di quel prezioso consiglio dato a Jesse durante la gara.
Questa è la storia di Luz Long, una storia che nei libri scompare silenziosa, quasi nascosta nell’ombra proiettata dalla figura gigantesca di Jesse Owens. Una figura diventata leggendaria, quella di Jesse, divenuta tale certamente per meriti propri, ma che deve l’immortalità a quell’incontro, nel posto sbagliato al momento sbagliato.
I grandi ricordi sono riservati a quegli uomini che con il cuore fanno grandi cose, nessun altro.
Spero che i miei figli non lo dimentichino mai.
—————————————————————————————
Un sentito e doveroso ringraziamento ad Alice Figini, “Storie di sport”, ad Alessandro Bacci, “Jesse Owens e Luz Long, l’amicizia che fece infuriare Hitler”, ad Antonio Rodà “Owens e Long, un’amicizia senza fine” e a Marcello Ierace “Luz Long e l’amicizia che sconfisse la guerra” per il prezioso supporto nella ricerca e ricostruzione storica. Allo stesso modo, anche tutti i riferimenti già esplicitamente citati nel testo.